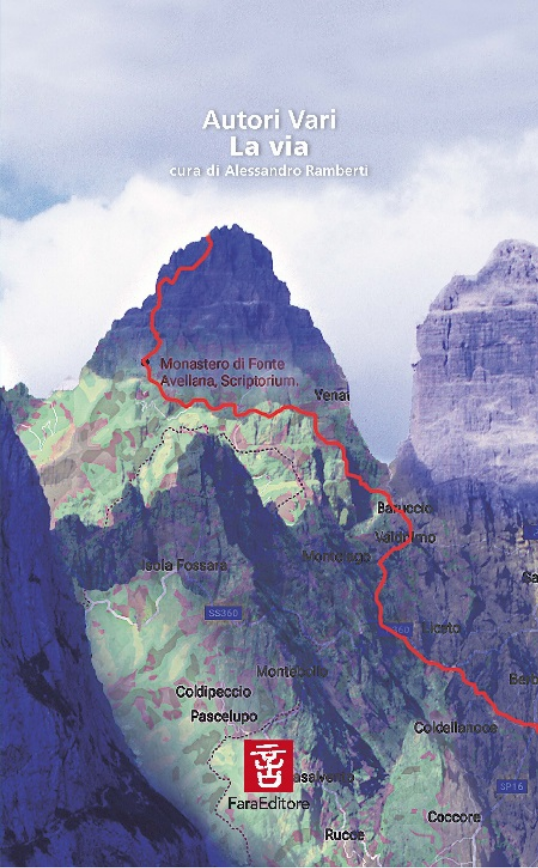La via
Autori Vari. La via.
A cura di Alessandro Ramberti
(Fara Editore, 2019)
Antologia con testi di vari autori sul tema della via
I miei testi
La parola come via: nell’inciampo della voce
Se portatrice di senso, la parola ˗ ascoltata o pronunciata ˗ traccia un cammino che ci consente di spostare il nostro punto di osservazione e/o di ridurre una distanza. Come la via collega un luogo a un altro, così la parola ci mette in contatto con noi stessi e con gli altri nel momento in cui la percorriamo.
Come si percorre una parola? Lasciandola risuonare, esplorando ciò che contiene, perfino inciampando nel nostro tentativo di comprensione, di comunicazione e di fedeltà al senso che si presenta di volta in volta. L’inciampo è la fatica necessaria, è ciò che ci impedisce di dare per scontato quello che crediamo un possesso, è la rimessa in discussione di ogni evidenza.
Il dire non circoscrive il senso, non lo recinta. Il senso infatti è tanto più vivo e vitale quanto più ampio è lo spazio tra la parola e l’immagine da essa evocata: non esiste una perfetta adesione, una coincidenza biunivoca tra il nome e l’idea suggerita. Ogni parola vera è una parola “poetica”, ovvero una parola che orienta lo sguardo ma che, al contempo, lo lascia libero di spaziare.
Ma lo spazio dischiuso dalla parola non è solo pensiero e immagine; lo spazio originato dalla parola è anche silenzio, non-parola, sospensione. È quel mistero irrinunciabile di cui è fatta ogni comunicazione. Al riguardo, vorrei citare l’esergo riportato all’inizio del mio ultimo libro, Midbar (Raffaelli Editore, 2019), che è una rilettura poetica di eventi, personaggi e archetipi dell’Antico Testamento:
“MiDBaR, deserto. DaBaR, parola. Il deserto come luogo della parola, che nasce nel silenzio e al silenzio ritorna, dopo aver attraversato distanze, pericoli, solitudini.
Ma DaBaR è anche evento. Una parola evento che si inscrive nel tempo, accettando i rischi del divenire e cercando non una comprensione che fossilizzi il senso, ma un’accoglienza che la rinnovi.
Nel deserto, che azzera l’orientamento e genera una visione sempre diversa, la parola evento inciampa di continuo su se stessa. Eppure è proprio il suo balbettare, il suo cadere e ricominciare che la rende vera e cosciente della sua povertà, bisognosa di un senso che la soccorra. Nel deserto, non si sopravvive da soli.
MiDBaR è dunque il luogo sia dello svuotamento che dell’incontro, entrambi necessari a una parola che, per esistere, deve farsi cassa di risonanza dell’alterità”.
Dabar
Ogni parola è un passo.
Cambia nel dirsi e nell’ascolto
come una distanza
raggiunta con il corpo
e superata.
Fonda flessuosa luce le cresce dentro
se in alto
o nella misura dell’appoggio
più spazio riesce a separare
l’immagine dal nome.
E il nome pronunciato
è già percorso.
Non c’è certezza di un inizio
sul cammino.
L’origine ci sfugge
come l’istante
in cui tutta la lingua si dispiega
e il bambino
di colpo sa parlare.
Ogni parola è un balbettare
forte dell’inciampo
con cui il suono
l’invera mano a mano.
Nasce dal deserto e non lo lascia:
mentre lo attraversa
ne spinge il confine più lontano.
E nel silenzio si vede
riflessa, incinta di echi
come il profeta
che muore
carico di futuro
sulla soglia
della terra promessa.
Il balbettare, l’inciampo della parola simboleggia la sua povertà, ovvero il fatto che non può contenere ciò a cui essa allude. C’è un “al di là” che non sarà mai circoscritto, uno scarto tra il dire e la realtà, sia esperita che immaginata. E questo scarto è ancora più grande quando il linguaggio vuole farsi specchio della dimensione sacrale della vita.
Tra i vari personaggi biblici, Mosè è l’esempio di questo limite umano, che al tempo stesso è una forza. Mosè è “impacciato di lingua”, incespica, non è un bravo oratore, eppure è proprio lui che dovrà trasmettere il messaggio di Dio agli uomini. In Mosè, a spezzarsi e a ricominciare di volta in volta non è solo la parola, ma la sua stessa identità: dal seno materno al fiume a cui è affidato dentro la cesta, dal fiume alla reggia dove vivrà a lungo, dalla reggia al deserto, dove condurrà il suo popolo per quarant’anni. Il popolo permetterà a Mosè di trovare una voce e un’identità, e viceversa. Sarà un cammino di crescita comune, una ricerca di senso all’interno di un bene collettivo, nella consapevolezza che ogni conquista è provvisoria e che solo l’ “Alterità” spinge il passo avanti, offre una possibilità di superamento dei propri limiti.
Un popolo
(il canto di Mosè)
“Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono stato né ieri né ieri l’altro e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua»” (Es 4,10).
Quante volte ti ho guardato
dall’insonnia
come si cerca
di tenere insieme
nella mente una parola
e invece
quella si spezza nel chiarore
balbuziente.
Quando la voce sogna
riunisce
il gregge dei suoi suoni
e il tempo le obbedisce.
Ma tu, popolo mio
ti spargi
come il mio nome
confuso si divise
tra il seno e il fiume
il trono e poi il deserto.
Adesso
in te
esco dai miei confini.
E non rinuncio
perché ti vedo:
sei tu, popolo incerto
che mi pronunci
passo a passo.
Infinito, incompiuto
il cielo
ci presta un tetto provvisorio
come il palato
su cui la lingua batte
e sfiora
il senso.
Ogni conquista è provvisoria, perché il senso va ricercato di continuo. Per questo, la parola più benefica è quella che interpella attraverso una domanda. La domanda, lo si dice spesso, è più preziosa della risposta: essa apre il cammino, che è riflessione e, insieme, scelta. Nella Bibbia, la domanda che Dio pone all’uomo non serve a Dio, ma all’uomo: lo spinge a interrogarsi sulla propria condizione e a prendere coscienza della responsabilità a cui nessuno può sottrarsi.
La domanda
“Ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai” (Gn 2,17).
“Guardiamo ch’egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell’albero della vita, e ne mangi, e viva in eterno” (Gn 3,22).
Prima del frutto
l’uomo
è eterno e non eterno:
zona d’ombra.
Ma interpellato
si forma
si vede come un luogo
dimora di partenze.
Sul volto
la natura si dispiega
nella scelta.
(non può
che essere mortale
per sopportare il male
dentro il bene).
L’uomo che è nato
nasce fino in fondo.
Esiste
se esiste
la Domanda
che non si chiude mai:
“Dove sei?”
La domanda permette all’uomo di rinnovarsi e consente al passato di farsi continuamente presente, di ritrovare vitalità all’interno della memoria collettiva.
Pe-sach
Passa la morte
oltre il rosso
degli stipiti
lungo i fianchi fasciati
l’ignoto
passa un soffio tra i giunchi
del mare
bifronte
la memoria sulle dune
che modella
passa l’arca
con stanghe mai tolte
sempre pronta
e di bocca in bocca
la domanda che incalza
rinnova il racconto
la vita oltre la morte
passa l’ala
tra il lutto e la salvezza
sulla porta.
La parola è però esposta a vari rischi: l’autoreferenzialità, la chiusura egotistica, la pretesa di poter definire l’indefinibile. Se ciò avviene, essa perde la sua unica, vera vocazione, ovvero la sua natura dialogica, e si allontana dalla vita, non è più trasmettitrice di bellezza, non è più in ascolto dell’uomo. Allora, invece di farsi via che congiunge, diventa muro divisorio. A Babele, gli uomini smettono di parlare gli uni con gli altri e rinunciano alle più semplici attività quotidiane, indaffarati in un progetto assurdo – i greci parlerebbero di hybris – che crea una fuorviante omologazione, una pericolosa indistinzione. La pluralità delle lingue non sarà dunque una punizione divina, ma un modo per tornare ad esprimere la vitale differenza tra individuo e individuo, e per “umanizzare” nuovamente la relazione con l’altro da sé.
Babele
Cercammo un nome
per paura della morte
squadrammo la parola.
E la parola-argilla
scordò che era terra
reclamò l’altezza di una torre
divenne più preziosa della vita.
Per lei
rinunciammo al tempo del riposo
alla carezza, allo spazio
che differenzia il senso.
Finché
fu il mondo un’evidenza
senza volto
– rumore
di fondo
che nessuno ascolta.
Ma nella dispersione
capimmo
che il nome dura solo
se dalla voce affiora
l’uomo.
La parola, che ha per vocazione quella di essere dialogica, deve comunque accettare soste e sospensioni. Come ogni cammino ha bisogno di pause, così la parola ha bisogno di tornare al silenzio da cui trae origine. Proprio nel momento in cui vuole avvicinarsi al mistero più profondo, deve fare i conti con l’assenza di certezze. Deve accogliere ciò che rimane incomunicabile.
Al silenzio mi sono riferita ad esempio in una poesia che riprende tre termini ebraici, considerati come un’anticipazione del mondo a venire: “shabbat”, il sabato come sospensione del tempo del “fare” e preannuncio di un tempo escatologico, “shemesh”, il sole come simbolo vitale per eccellenza, “tashmish” come contatto corporeo che genera intimità all’interno del mistero ineliminabile dell’altro. La pronuncia di queste tre parole una accanto all’altra “shabbat, shemesh, tashmish” mi ha fatto pensare a un invito al silenzio: “shhh…”
Assaggio del mondo a venire
Shabbat, shemesh, tashmish
sono assaggio
del mondo a venire:
il riposo, il sole, il contatto
dei corpi.
Shabbat, shemesh, tashmish.
Nel tempo alloggia
l’eterno
nel raggio disperso
il ritorno
e il dono
nel piacere più geloso.
Shabbat, shemesh, tashmish.
L’assenza è pregustata
come fosse
già adesso
intimità.
Shabbat, shemesh, tashmish.
E un sussurro silenzia
con un bacio
la realtà.
Lo stesso Dio, in uno dei passaggi più poetici dell’Antico Testamento, sceglie come strumento di auto-rivelazione non una parola-concetto o una manifestazione di potenza, ma un “suono di silenzio sottile”, che al posto di offrire una spiegazione fa percepire a chi l’avverte (in questo caso al profeta Elia) una presenza confortante, aperta al futuro.
Il Dio delle dieci Parole è “suono di silenzio sottile” forse per ricordarci che la parola è fatta anche di silenzio, ovvero di tutto ciò che è in continuo divenire e che non può essere né previsto, né preannunciato distintamente.
Qol demamah daqah
“E un vento fortissimo che spacca montagne e spezza le rocce era davanti al Signore. Non nel vento, l’Eterno. E dopo il vento, un terremoto. Non nel terremoto, l’Eterno. E dopo il terremoto, un fuoco. Non nel fuoco, l’Eterno. E dopo il fuoco, un suono di silenzio sottile. Come l’udì, Elia s’avvolse il viso nel mantello e uscì sulla soglia della grotta” (1 Re 19, 11-13).
Non vento di bufera
frastuono
non fuoco o tremore
non guerra, non pace
ma bocca che si apre
senza suono.
L’Eterno
è silenzio sottile
che ti vuole e che non rivela
niente: solo
ti concede un respiro
e un’ansia più mansueta.
Rinunci a capire:
è il tuo modo
di attendere il futuro
perché la conoscenza
è un’illusione.
Il vero si fa strada
se i sensi sono arresi
complici del dubbio.
E mantice
l’assenza.
Personalmente, quando penso all’impensabile a cui si è dato nome “Dio”, credo che l’essenziale non sia afferrare un concetto, ma compiere un passo, come risposta a un invito. In questo senso, tutti noi, nel modo in cui intessiamo legami con la vita e con gli altri, creiamo Dio, lo inveriamo tramite il ripetersi quotidiano del nostro sforzo.
Ho tentato di esprimere proprio questo nella poesia con la quale desidero ora concludere, tratta dalla raccolta “L’ultimo quarto del giorno” (La Vita Felice, 2018):
Sei così Altro
dal sommo appiglio
dalla ragione dallo sbaglio
che sei anche me.
Lo sei in quest’ora.
E dislocato nella parola
rivolta senza sosta
sei il tempo che mi occorre
per darti
una risposta. Non prima
ti esaurisci.
Sei il modo in cui mi riesce
balbettando
di arrivare fino in fondo.